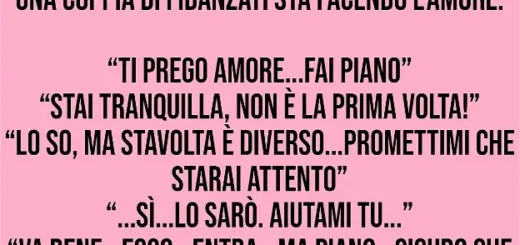Testimoni di Geova, la rivelazione di chi ne è uscito: “Non avete idea di cosa accada veramente..”
Torino e la provincia di Agrigento. Vengono da questi poli opposti dell’Italia le storie di due ex testimoni di Geova, che si sono messi in contatto con la nostra redazione durante la realizzazione della prima parte dell’inchiesta di ParmAteneo sui TdG. Un articolo che ha raccontato questa realtà da dentro, attraverso le testimonianze di chi guida la congregazione e di chi ha deciso di entrarvi. In questa seconda puntata abbiamo quindi dato voce a un “fuoriuscito“che ha lasciato spontaneamente la propria comunità e a un “disassociato“, termine che indica i TdG costretti dalla congregazione ad allontanarsi.
Tanti punti in comune e alcune diversità ci hanno spinto a scegliere le loro due storie, emblematiche di quell’altra faccia della medaglia del dibattito aperto che coinvolge i Testimoni di Geova tra complesse e sfaccettate questioni. Volutamente ci siamo focalizzati sulle dinamiche interne di una congregazione e sulle conseguenze psicologiche che possono presentarsi per chi è uscito dai TdG, ritrovandosi costretto a costruirsi faticosamente una nuova vita.
Qual è l’esperienza diuna persona che nasce e cresce all’interno dei TdG, con i riflessi nella vita quotidiana che comportano le regole di questo credo? ABRAMO – “Racconto la mia storia per la prima volta, non la conosce quasi nessuno”. A parlare è Abramo, 40enne torinese, nato in una famiglia di TdG e cresciuto in una congregazione, battezzato a 14 anni e oggi disassociato. L’infanzia che racconta è un’infanzia difficile e opprimente. “Stavo in un ambiente in cui mi si diceva tutti i giorni cosa fare, cosa leggere, cosa pensare, tutte le azioni erano programmate“, spiega, sottolineando come fosse impossibile avere rapporti normali con il “mondo fuori” a causa dei dettami imposti dagli anziani.
“Alle elementari non potevo andare a nessuna festa di compleanno, avevo 6 anni e non sapevo che dire ai miei compagni di classe perché già mi vergognavo. Non potevo stare con i miei amici, mi vergognavo del fatto che non potessi mangiare una torta per paura che qualcuno lo dicesse ai miei genitori, dicevo di avere mal di denti”. Al dispiacere di non poter festeggiare compleanni – ma nemmeno festicciole di Natale, Carnevale o altre festività, come impongono le regole della comunità – si aggiungeva un terrore costante di essere visto trasgredire alle regole, e non solo.
“Un bambino cresce sapendo di dover fare la spia“, nel caso veda un amico infrangere una norma. Ma cosa succede in tal caso? “C’era una violenza psicologica costante: alle adunanze sentivo tutti i giorni di un Dio geloso, che uccideva, che ti puniva se non facevi quello che lui diceva. Tutto però veniva condito con la frase “questa è la verità, è un Dio d’amore” continua Abramo, aggiungendo che anche i bambini potevano subire i processi da parte degli anziani, ovvero riunioni in cui il “peccatore” viene redarguito davanti a tutti. Ma nel caso di Abramo le prevaricazioni non finivano qui. “Non c’era solo violenza psicologica, nella mia famiglia c’era anche violenza fisica. E c’erano tante famiglie come la mia che vivevano di botte, terrore e religione“.
Una quotidianità mai serena, dunque, in cui “non si poteva nemmeno guardare la televisione se non la sera, e appena c’era un bacio si spegneva subito. Tutto veniva visto come morboso. Dovevi mantenere un autocontrollo così pesante che rischiavi di autodistruggerti”. Controllo esercitato anche sul linguaggio, dal momento che “parole come ‘amico’ o ‘compagno’ riferito a una persona del ‘mondo fuori’ andavano evitate”. Per tutto questo Abramo però non incolpa la famiglia. “Non posso essere arrabbiato con i miei, erano delle vittime anche loro. Questa è stata la mia infanzia. La prima volta in cui io ho pensato di togliermi la vita è stato a 5 anni – aggiunge Abramo -. Volevo buttarmi dal balcone, ci pensavo tutti i giorni della mia vita”.
Durante l’adolescenza la situazione non diventa più facile. “Dai 14 ai 16 anni ho passato quasi tre anni chiuso in casa in una depressione devastante, andavo solo alle adunanze, i miei non se ne sono neanche accorti – racconta -. Se non ti comporti in un certo modo non hai diritto all’affetto, né delle persone intorno né della tua famiglia. L’affetto era direttamente proporzionale all’impegno che mettevi nello studio e nella predicazione. E poi arriva il momento di fare i conti con i propri ormoni: tu sei un ragazzo adolescente e ti viene insegnato che il sesso è una cosa assolutamente bandita, così come la masturbazione.
Allora ci si sposa presto, non si hanno alternative, ma così nascono matrimoni fra persone che non hanno complicità, intimità. Vuol dire che si creano nuovi nuclei famigliari malati”. A questo punto della sua vita, l’alternativa di Abramo è stata condurre due vite parallele: mentre fuori dalla congregazione viveva le normali esperienze adolescenziali, dentro si guadagnava il benvolere degli anziani, che tuttavia lo guardavano sempre con sospetto. “In qualche modo ero protetto da alcune persone. C’è un nepotismo all’interno che fa schifo – continua Abramo -.
A 16-17 anni sono stato preso sotto l’ala protettrice di uno che era considerato un vescovo, sopra gli anziani, e molti di questi volevano ‘colpire’ me per far ricadere le conseguenze su di lui. C’è una rete di vendette all’interno delle congregazioni, le gerarchie sono tutte avide di potere”. Una vita quotidianamente in bilico fra due esistenze opposte, con la consapevolezza di volersi sempre più allontanare, vedendo allo stesso tempo gli amici rimanere fermi nella realtà dei TdG. “Uno degli amici della mia infanzia è diventato un anziano – ricorda Abramo -. A 20 anni eravamo in macchina e gli chiesi ‘hai mai pensato di uscire fuori?’. La sua risposta mi ha raggelato: ‘Abrà, ma cosa posso fare io fuori?’. Non ha mai avuto alternative”.
Dopo aver subito quattro processi, Abramo è definitivamente uscito dai Tdg a 22 anni, dopo che già una prima volta se ne era allontanato per poi tornare sui suoi passi per il legame con quella che all’epoca era la sua fidanzata. “La prima volta sono stato buttato fuori perché stavo con una ragazza della congregazione, con cui c’era stato altro… – ricorda – ma per come era cresciuta, ha vissuto la cosa coi sensi di colpa. Mi diceva ‘dobbiamo confessare il peccato che abbiamo commesso’. Lei l’ha fatto e abbiamo subito un processo”, spiega. “Le persone rientrano solo per gli affetti perché si crea un ricatto emotivo. Sono rientrato per lei ma un anno dopo sono ri-uscito per sempre. Era il 2000″.
Per Abramo sono stati necessari 16 anni di terapia psicologica per superare quanto vissuto. “In quei 16 anni ho avuto relazioni disastrose, non mi era mai stato insegnato l’amore. Quando una persona esce si ritrova da sola, non ha amici e i parenti all’interno non possono salutarli”.
GIUSEPPE – “Un discorso è avvicinarti di tua spontanea volontà a una dottrina, un altro è quando ti viene imposta”. Inizia così Giuseppe, 30enne siciliano e attualmente residente a Parma. “Sono nato da genitori TdG, le loro famiglie si sono incontrate in Sicilia e fondamentalmente hanno combinato il matrimonio fra mio padre e mia madre – racconta – e continuano a vivere il loro rapporto con questa religione in modo maniacale”. Giuseppe, tuttavia, è ancora in contatto con i suoi genitori. “Non mi sono mai battezzato, quindi non sono un disassociato, non sono stato cacciato fuori. Altrimenti non potrei parlare con la mia famiglia”. Anche per Giuseppe l’infanzia non è stata per nulla semplice, soprattutto perché vissuta in un paesino siciliano di 5000 abitanti nella provincia di Agrigento. “Ero obbligato ad andare alle adunanze tre volte a settimana e a predicare con la borsetta e i volantini.
Vivevo la predicazione come un’umiliazione totale. A 5 anni e mezzo ho avuto il mio primo discorso davanti a 80 persone TdG perché ti addestrano fin da piccolo – racconta -. Vedevo passare i miei compagnetti di scuola che andavano a giocare e io stavo lì, in giacca e cravatta con la borsetta a predicare. Ero molto deriso e preso in giro”. Un senso costante di inadeguatezza, dunque. E poi, la solitudine. “Potevo avere solo amici della mia religione, ma i TdG nel mio paesino erano appena 60 e non c’erano altri della mia età fra loro” ricorda Giuseppe, costretto anche lui come Abramo ad evitare qualunque contatto con gli altri bambini. “Mi erano vietate tutte le feste perché sono pagane. Ma anche andare a casa dell’amico o a fare compiti da un altro… qualsiasi svago che avrebbe comportato frequentare la gente del mondo, come la chiamano loro. L’insegnante che più mi ha rispettato è stata quella di religione, mentre altri volevano costringermi a fare cose che non potevo fare: la festicciola di Natale, come poteva capitare a sorpresa il compleanno di un compagno, ma tu dovevi stare in un angolo senza dover accettare la Coca cola, la torta o le patatine. Eri sempre isolato e diverso. Non ho mai festeggiato un compleanno in vita mia, non mi è mai stato fatto un regalo”.
L’esclusione e le umiliazioni sono andate avanti anche in seguito. “L’età più brutta è stata quella delle medie. Con gli altri ragazzi si arrivava molto alla svelta alle mani, mi picchiavano, ero quello diverso – continua Giuseppe, ricordando anche il conflitto con la famiglia – Se tornavo a casa piangendo perché avevo avuto una lite e le avevo prese, mio padre si incazzava perché dovevo farmi rispettare. Se invece le avevo date, si incazzava lo stesso perché dovevo perdonare il prossimo”. Tra “insicurezze e mancanza totale di autostima” Giuseppe riesce però lentamente ad allontanarsi da quella realtà. “Un grandissimo aiuto è venuto dai miei fratelli che mi hanno aperto la strada. Loro fino ai 18 anni sono stati costretti ad andare, io invece già a 14 anni stavo fuori”. Nonostante abbia mantenuto i rapporti con la famiglia, le conseguenze di una gioventù vissuta così rimangono nel presente di Giuseppe. “Il passato continua a influenzarmi tantissimo, è un’esperienza che purtroppo mi ha segnato negativamente a vita. Si ripresenta nel quotidiano”.
Sia Abramo che Giuseppe concordano nel ritenere i Testimoni di Geova come una vera e propria “setta”, che ha fatto e che continua a “fare il lavaggio del cervello a tante persone”. “Come ogni setta negano di esserlo” . Ma è il loro passato a spingerli a dire questo o c’è un fondo di verità? LA VOCE DI UN’ESPERTA – A fare luce su questo può essere l’esperienza di Lorita Tinelli, psicologa di indirizzo clinico forense che insieme ad alcuni colleghi ha fondato nel 1998 il Cesap, il Centro Studi Abusi Psicologici a Vernole, in provincia di Lecce, di cui attualmente è vicepresidente. Si tratta di una onlus di diritto che fornisce assistenza alle vittime di controllo mentale e abuso psicologico da parte di sette e gruppi a carattere totalitario. Questo l’ha portata a studiare con attenzione i Testimoni di Geova e le loro comunità. “Ce ne occupiamo da molto tempo – racconta Tinelli –. Ci arrivano segnalazioni di continuo, spesso a causa di uno dei punti nevralgici della dottrina dei TdG: l’ostracismo. Infatti, chi dissente o inizia a farsi domande viene estromesso e nessuno, né la famiglia né il gruppo, può parlarci o addirittura salutarlo”. Un atteggiamento che mina la stabilità di un individuo. “É devastante dal punto di vista psicologico e umano: sono dettami che vanno oltre i normali legami affettivi e possono comprometterli in maniera irreparabile. Non è raro che qualcuno pensi al suicidio – prosegue Lorita –. Ci sono stati gravi denunce, inerenti alle regole interne e, ultimamente, anche per casi di pedofilia che tutt’ora sono al vaglio della magistratura”.
Ma cos’ha portato il Cesap ad occuparsi direttamente di questi casi e ad intervenire? “Quando ci si riferisce ai Testimoni di Geova si può parlare senza dubbio di controllo mentale, comportamentale e dell’informazione – spiega la psicologa – questo perché la logica dei TdG è quella di un gruppo direttivo che impone delle regole sulla vita personale di ciascun membro. C’è un’organizzazione piramidale, con a capo poche figure che hanno il controllo totale sugli altri. Poi ci sono i sorveglianti, gli anziani e molti ancora. Ognuno ha il suo ruolo, fino ad arrivare ai proclamatori che promuovono i libri e le riviste. Le parole di questi testi, ovviamente, non vengono mai messe in dubbio. É il loro cibo spirituale, che dà indicazioni su tutti gli aspetti di vita, personali e collettivi”. E sono proprio questi aspetti ad identificarli, tecnicamente, come una “setta”, un altro dei territori dove agisce il Cepas. “Si può parlare di setta perché è un gruppo chiuso che vuole estraniarsi del mondo – risponde Tinelli, che spiega– I TdG sono così, separati dalla società. Vedono le cose attraverso un pensiero dicotomico: bianco/nero, buoni/cattivi. Tutte caratteristiche che possono essere definite settarie”. Infatti, ‘setta’, come ricorda la psicologa, viene dal latino ‘secare’, cioè dividere, separare. “Il termine viene usato per indicare un gruppo che ha caratteristiche rigide, di divisione tra quello che sta dentro e quello che c’è fuori”.
Eppure, nonostante questa forte chiusura, non sono poche le persone che decidono di avvicinarsi, anche affrontando un lungo percorso. “Entrare nei testimoni è una scelta emotiva, non razionale – aggiunge Lorita – A parte quelli di seconda generazione, che ci sono nati, chi entra dopo lo fa perché ha un bisogno, una necessità. Non c’entra la cultura o la formazione scolastica. Ho conosciuto gente plurilaureata che in un momento difficile ha accettato quel tipo di messaggio. Da un punto di vista delle personalità, aderisce più facilmente chi ha un bisogno di ordine, di pulizia e di regole”.
Allo stesso modo, uscirne può essere legato ad una particolare condizione emotiva, e non meno difficoltoso. “Chi esce lo fa perché si è disinnamorato: la passione e il coinvolgimento finiscono. Una fuoriuscita – confida la psicologa – mi ha proprio detto che le era ‘caduto il prosciutto dagli occhi all’improvviso’. Nasce il dubbio e la sfiducia e così si cerca di allontanarsi. Allora interviene il comitato giudiziario dei TdG e avviene un vero e proprio processo. Una volta finito, chi è fuori non potrà più avere contatti con i proprio amici rimasti dentro o con i familiari. Per questo, nascono forti sensi di colpa e di inadeguatezza, tanto che qualcuno chiede di rientrare e deve affrontare una serie di punizioni imposte dalla congregazioni”. Il percorso risulta più arduo e difficile soprattutto per chi all’interno delle comunità ci è nato, spiega Lorita parlando di alcuni ragazzi usciti dopo vent’anni passati nelle congregazioni. “Quando sei fuori è un po’ come dover iniziare a camminare e a parlare. Sono terrorizzati, spaesati e non riescono a decodificare gli stimoli dell’ambiente esterno. I figli dei testimoni, quando sono piccoli, non possono partecipare alle attività di classe, ai compleanni dei compagni e questo danneggia il loro sviluppo. Non intrattengono mai relazioni autentiche con i loro coetanei. Quando escono dalla comunità hanno problemi a socializzare, ad avere relazioni sentimentali e a farsi una famiglia. Fanno fatica anche dal punto di vista sessuale, visto che per i TdG il sesso è demoniaco”.
Un’educazione impartita fin dalla tenera età che talvolta può scaturire in imposizioni anche violente. “Ci sono famiglie violente all’interno della congregazioni – aggiunge Tinelli –. Per onestà dico che ci sono nuclei famigliari più moderati, ma non sono tanti. É un problema insito nella struttura piramidale della comunità. É dannosa. Un gruppo che professa una verità assoluta è già un gruppo che ha qualche difficoltà. La comunicazione è chiusa, c’è poca trasparenza e la gente non accede alle informazioni che al livello più basso non vengono mandate. Sono tutte situazioni di non chiarezza e di scarsa democrazia”. ARTICOLO DI Chiara Micari scritto su ParmAteneo.